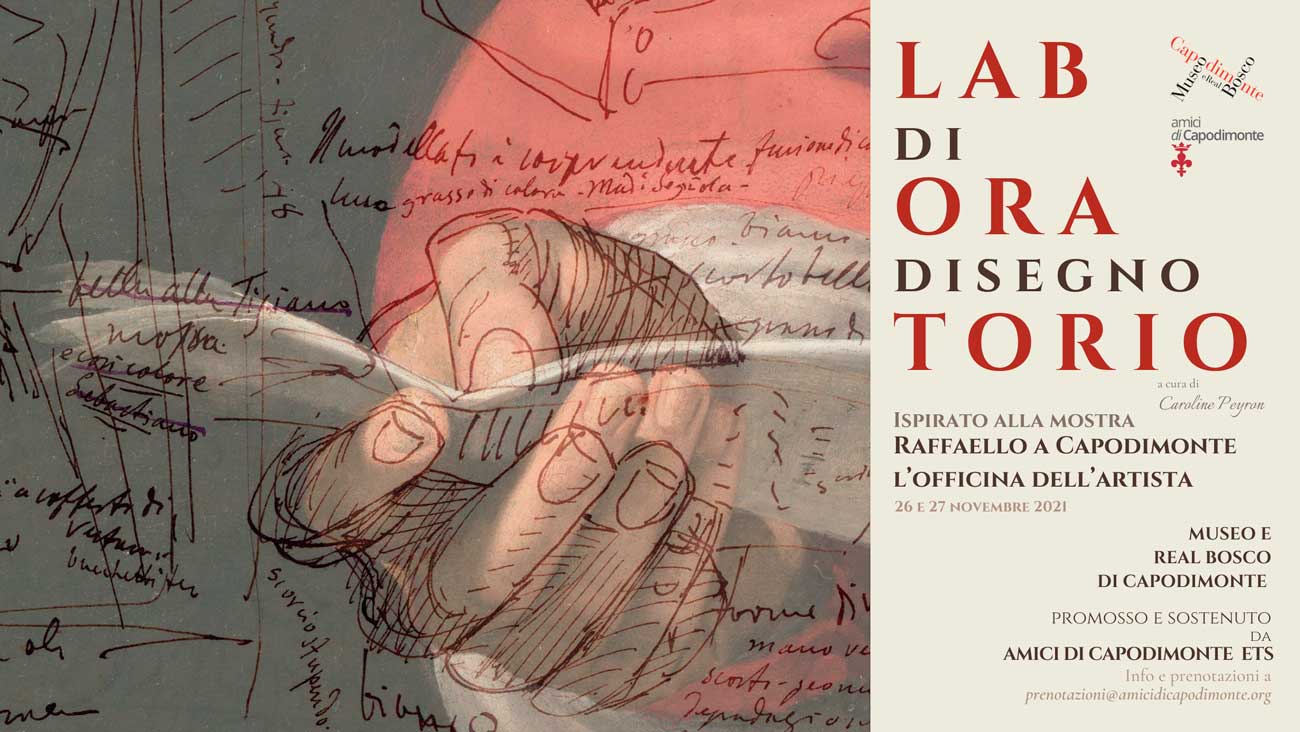L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… Antonine Moine e la rappresentazione del pescatore napoletano nella scultura francese del Romanticismo
Per la rubrica L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta… Jean-Loup Champion, storico dell’arte e co-curatore della mostra Gemito, dalla scultura al disegno (10 settembre – 15 novembre 2020), ci racconta l’iconografia del pescatore napoletano e il ruolo nella scultura francese del Romanticismo di Antonine Moine (1796-1849), talento affascinante, autore del bronzo Pescatore napoletano addormentato.


L’iconografia del pescatore napoletano, coi pantaloni corti, la camiciola dalle maniche arrotolate e il rosso berretto frigio fa parte dell’immaginario europeo fin dal Settecento: si ritrova nei resoconti di viaggio e nelle immagini del Grand Tour, ed evoca immediatamente i lazzaroni, i ragazzi del popolo napoletano spensierati, allegri e scansafatiche che vivevano alla giornata.
Da Goethe che nel 1785 descriveva i pescatori sdraiati al sole, al famoso dizionario Larousse, che nel 1874 restituiva un’immagine oleografica:
“le persone umili vivono nell’ozio e nella miseria, senza che questo stato alteri in alcun modo il loro umore gioioso“.
Tra i luoghi comuni universalmente condivisi sulla storiografia napoletana, l’immagine ricorrente è quella pittoresca del pescatore, divulgata da gran parte degli artisti stranieri, in primis dal paesaggista tedesco Franz Ludwig Catel (1778-1856), che diede luogo ad una vera e propria moda, emulata da pittori e scultori soprattutto francesi nella stagione del romanticismo.

Sono queste le premesse in cui si inserisce il bronzo dello scultore Antonin Moine, il Pescatore napoletano addormentato, datato 1838, ed entrato per donazione nelle raccolte del Museo e Real Bosco di Capodimonte.
Per comprendere meglio la sua genesi è necessaria una piccola introduzione sulla scultura in Francia durante il regno del re Luigi Filippo d’Orléans: la Monarchia di luglio (1830-1848).
Se il romanticismo francese è molto celebrato in pittura attraverso le opere di Eugene Delacroix, di Théodore Géricault, le cui caratteristiche peculiari di maggiore impatto emotivo nel coinvolgimento dello spettatore segnarono una vera e propria rivoluzione, auspicata in particolare da Géricault che, a partire dagli anni Venti del XIX secolo, si oppose al neoclassicismo dominante; sono molto meno conosciuti gli sviluppi del romanticismo francese sul versante della scultura.
Il neoclassicismo è rivolto verso l’antichità greca e romana, che ci è pervenuta soprattutto attraverso la scultura.
La pittura neoclassica guarda alla scultura, mentre la scultura romantica guarda alla pittura, desiderosa di integrarne il movimento, la materia e il colore.
Théophile Gautier nella sua Storia del Romanticismo scrive:
“David d’Angers, Auguste Préault, Antonin Moine, Maindron, Mademoiselle de Fauveau, Barye, hanno rappresentato, nella scultura, il nuovo movimento dell’originalità e della libertà”.
La maggior parte di questi artisti non aveva seguito una formazione di studi all’Accademia di Belle Arti e pertanto era di fatto esclusa dalle più importanti commissioni pubbliche.
Tuttavia, il primo di questi pescatori romantici esposto al Salon del 1831 è quello di un artista di stretta formazione accademica, che aveva vinto il Primo Gran Premio al concorso dell’Accademia di Francia a Roma nel 1812: François Rude (1784-1855), autore della Partenza dei Volontari del 1792, detto La Marseillaise, che adorna uno dei pilastri dell’Arco di Trionfo sulla Place de l’Etoile a Parigi.
Ironia della sorte, dopo aver vinto il premio, Rude non andò a Roma, ma seguì la moglie a Bruxelles.

Quando Rude espose nel 1831 il gesso del Giovane Pescatore napoletano che gioca con una tartaruga, la scultura si evidenziò per la novità del soggetto e il realismo con cui era trattato.
La versione in marmo, esposta al Salon del 1833, sarà ancora più apprezzata per il verismo dei dettagli, in cui si distingue la qualità materica delle ciocche di capelli bagnate che sfuggono dal berretto di lana infeltrita.
Alexandre Dumas vide al Salon la scultura di Rude, ma gli preferì il bronzo di Francisque Joseph Duret (1804-1865) dall’analogo soggetto, il Giovane Pescatore che balla la tarantella. Souvenir di Napoli.
Duret aveva un percorso di formazione accademico simile a quello di Rude: vinto il Prix de Rome, aveva vissuto nell’Urbe dal 1824 al 1828.

Entrambe le opere sono legate al romanticismo sia per il pittoresco del soggetto, che per la ricerca della verità nella posa e nei dettagli.
Ne furono tratte riduzioni in bronzo che conobbero un grande successo: le statuette di Jean Auguste Barre, Antoine-Louis Barye, Carle Elshoect e Antonin Moine divennero in breve tempo di gran moda negli interni parigini, sia borghesi che aristocratici, come elemento ornamentale per le mensole dei camini.
Sin dalla sua biografia il profilo di Antonin Moine si delinea come l’archetipo dell’artista romantico: povero, privo di una formazione accademica – anche se allievo di Girodet e di Gros – che gli precluse l’accesso ad importanti commissioni pubbliche, con la sola eccezione del grande fonte battesimale in marmo per la chiesa della Madeleine a Parigi, mai ultimato.
Incapace di provvedere ai bisogni della sua famiglia, si tolse la vita con un colpo di pistola il 18 marzo del 1849, morte atroce immortalata da Victor Hugo, che annotò nel suo diario in Choses vues:
“Antonin Moine, un nome che d’ora in poi riporterà due ricordi, una morte orribile, un talento affascinante“.
Per anni, Moine era sopravvissuto vendendo modelli di statuette, spesso in stile medievale, che venivano poi tradotte in bronzo.
Il suo Pescatore napoletano addormentato fa parte di questo filone romantico inaugurato nel Salon del 1831.
Moine, senza essere mai stato in Italia, raffigura un ragazzino addormentato accanto alla sua barca, la cui idea viene suggerita dalla presenza di un remo nella scultura; indossa tutti gli attributi del pescatore napoletano desunti dal gusto pittoresco: il cappello di feltro, la croce appesa al collo, dei fiori.
La composizione evoca la posa classica – nella testa appoggiata sulla mano – della Malinconia, e si ritrova nel celebre Sonno di Endimione dipinto dal suo maestro, il pittore Girodet.

Di questa statuetta sono note diverse redazioni, tutte recanti il marchio della fonderia Debraux, come quella conservata al Museo Girodet di Montargis, e tutte della stessa misura, cm 16 x 34,5; è noto anche il bronzo, realizzato intorno al 1840, pubblicato nel catalogo della mostra Un âge d’or des arts décoratifs 1814-1848 tenutasi nel 1991 al Grand Palais.
Il bronzo donato al Museo e Real Bosco di Capodimonte è originale e unico: reca sia la firma di Antonin Moine che il marchio Debraux e la data 1838.
Le sue dimensioni, cm 27 x 47, sono molto maggiori dei multipli in bronzo noti, pertanto non è stato derivato dallo stesso calco, peculiarità che, allo stato attuale degli studi, lo qualifica come unicum, una rara e significativa testimonianza della scultura romantica francese, in cui si documenta la predilezione per la figura pittoresca del pescatore napoletano.
L’opera di Moine è stata recentemente presentata nella mostra Gemito, lo scultore dell’anima napoletana al Petit Palais di Parigi dal 15 ottobre 2019 al 26 gennaio 2020 e, successivamente, è stata donata al Museo e Real Bosco di Capodimonte.
Il prossimo settembre sarà esposta a Capodimonte nella mostra Gemito dalla scultura al disegno.
Il confronto con le opere di Vincenzo Gemito è particolarmente interessante: i pescatori napoletani di Rude, Duret e Moine, ammirati dai contemporanei per la loro naturalezza e per il superamento dell’ideale classico – il segno più forte dei romantici – non riescono ad accantonare completamente l’antico e lo coniugano al pittoresco.
Gemito riprenderà lo stesso soggetto, indagandolo con occhio crudo e acuto, dall’interno della realtà quotidiana dei giovani pescatori napoletani; è uno sguardo autentico che inserisce aspetti autobiografici.
A Parigi, nel 1877, avrebbe fatto un vero e proprio salto di qualità esponendo la figura, che sarebbe poi stata definita dalla critica “ripugnante”, del suo Pescatore, il manifesto assoluto del verismo napoletano.
Bibliografia: Jean-Loup Champion, Antonin Moine (1796-1849), sculpteur romantique, Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, année 1997, 1998, p. 251-274.
Il testo di Jean-Loup Champion è inserito nell’iniziativa “L’Italia chiamò – Capodimonte oggi racconta”
Della stessa rubrica puoi leggere:
5 maggio 1957: nasce il Nuovo Museo di Rosa Romano
Oltre il diluvio di Filippo Palizzi di Maria Tamajo Contarini
Stele di Lucio Del Pezzo di Angela Tecce
Colantonio di Pierluigi Leone de Castris
L’opera di Conrad Friedrich Dehnhardt nel Real Bosco di Capodimonte. La Natura che diventa Arte di Sara Cucciolito e Carlo Verde
Il ritorno dalla Festa di Piedigrotta di Filippo Cifariello di Maria Elena Maimone
Il trittico della Scorziata: un’opera ritrovata di Marina Santucci
Giuditta decapita Oleferne di Artemisia Gentileschi di Maria Cristina Terzaghi
Il Tiziano napoletano di Andrea Zezza
L’Estasi di Santa Cecilia di Bernardo Cavallino di Riccardo Lattuada
La Liberazione delle opere d’arte durante la Seconda Guerra Mondiale di Giovanna Bile
Il futuro digitale inizia oggi di Giovanni Lombardi
Francesco Barberini, Antonio Giorgetti e il medaglione allegorico di Luca Olstenio di Alessandro Mascherucci e Yuri Primarosa
Giuseppe Renda e il rinnovamento della scultura a Napoli tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento di Diego Esposito
La fuga in Egitto di Battistello Caracciolo di Christopher Bakke
L’Effetto Flora di Patrizia Piscitello
La Flora Farnese di Filippo Tagliolini di Maria Flavia Lo Regio
Hector! Chi era costui? di Antonio Tosini
L’Elemosina di Sant’Elisabetta d’Ungheria di Bartolomeo Schedoni di Marco Liberato
Capemonte mm’ha dato Ammore e Vvita! di Gianna Caiazzo e Giuseppe Murolo
Napoli Napoli: un allestimento, un’estate, un ricordo di Francesca Dal Lago
Il restauro del Buon Samaritano di Luca Giordano di Sara Vitulli, presentazione di Stefano Causa
Il Real Bosco di Capodimonte: l’arte che respira di Carmine Guarino
La Resurrezione di Cristo di Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma di Patrizia Piscitello
Il trittico con le Storie della Passione di Paola Giusti
La Crocifissione di Masaccio di Alessandra Rullo
L’intervento conservativo dell’opera di Mario Merz Onda d’urto di Simonetta Funel
Onda d’urto di Mario Merz di Ophilia Ramnauth e Luciana Berti
L’inaugurazione virtuale della mostra Luca Giordano di Patrizia Piscitello e Alessandra Rullo
Il racconto virtuale della mostra Luca Giordano di Sylvain Bellenger, video di Carmine Romano
La mostra Luca Giordano. Dalla Natura alla Pittura di Stefano Causa
Il bacio della nonna di Gioacchino Toma di Alessia Attanasio
Il Crocifisso ligneo del Monastero di San Paolo a Sorrento di Gennaro Galano
La Galleria fotografica di Mimmo Jodice di Giovanna Bile
Il servito da tavola di Manifattura Del Vecchio di Alessandra Zaccagnini
Gli scarti di fabbrica della Manifattura di Capodimonte di Maria Rosaria Sansone
La Madonna del Divino Amore di Raffaello di Angela Cerasuolo
L’archibugio per Ranuccio I Farnese di Antonio Tosini
Il restauro della Natività di Signorelli di Liliana Caso
La Chiesa di San Gennaro di Liliana Uccello
Gemito, o’ scultore pazzo di Sylvain Bellenger
Vesuvius di Andy Warhol di Luciana Berti
Le acquisizioni della Real Casa dal 1870 al 1912, Gemito e non solo di Maria Tamajo Contarini
“Gemito, dalla scultura al disegno” con i contributi di Carmine Romano, Roberto Cremascoli, Sylvain Bellenger
Vincenzo Gemito di Jean-Loup Champion
Il museo di Molajoli e de Felice nel 1957 di Rosa Romano
Le vaccinazioni alla Reggia di Benedetta de Falco
La Letizia di Canova di Alessia Zaccaria
Il Bosco Reale di Nunzia Petrecca
Come nasce la passione per l’arte di Marco Liberato
La Cassetta Farnese di Patrizia Piscitello
Da Frisio a Santa Lucia di Eduardo Dalbono di Paola Aveta
Ercole al Bivio di Annibale Carracci di Valentina Canone
Il Ritratto di Fra Luca Pacioli di Alessandra Rullo
Seguite gli aggiornamenti sul nostro blog e i nostri canali social